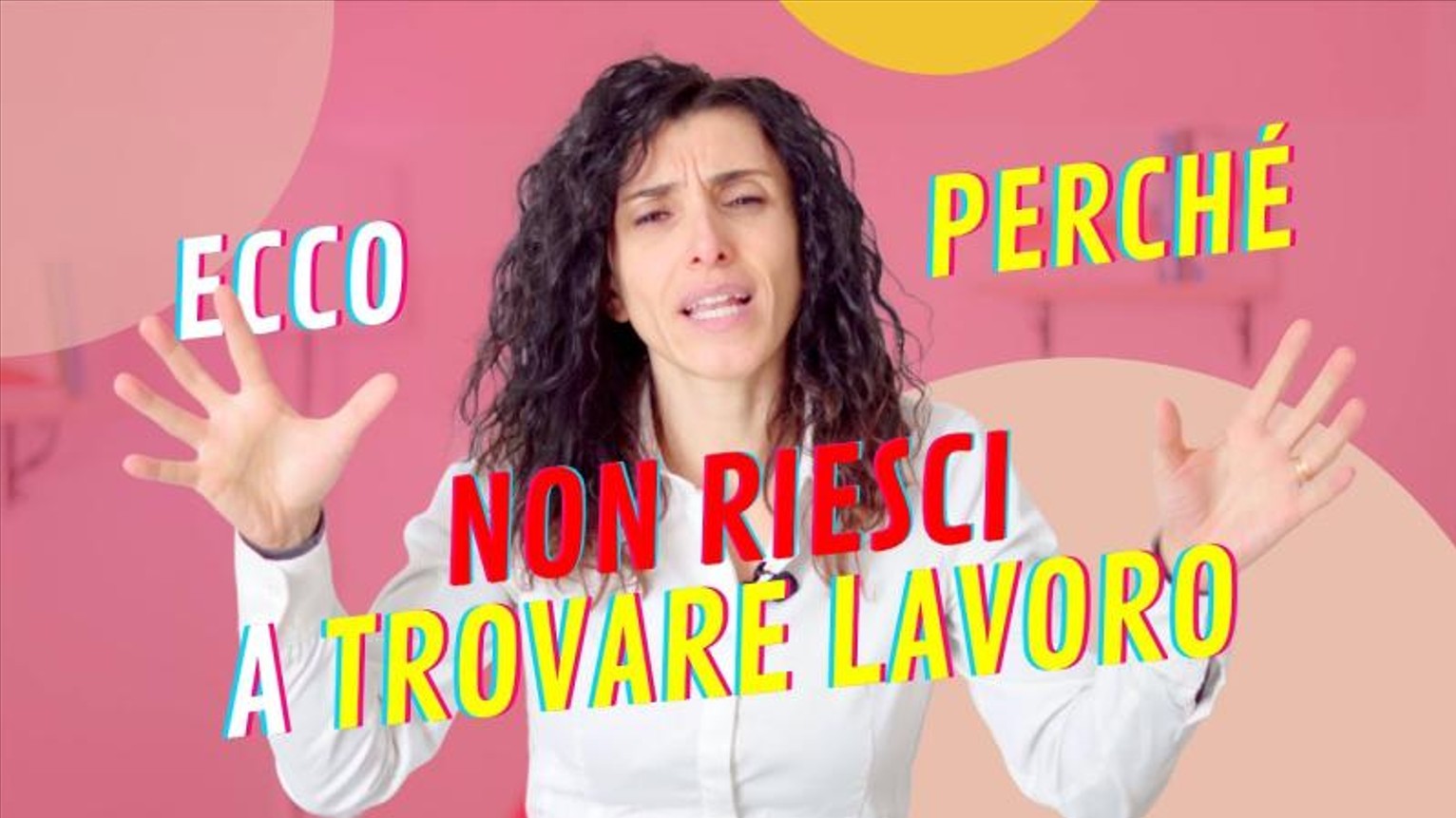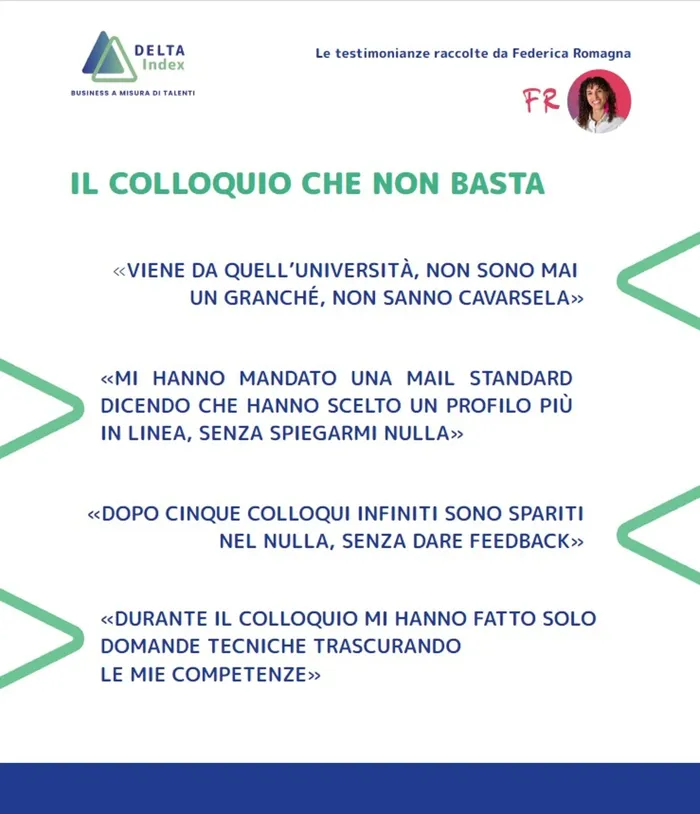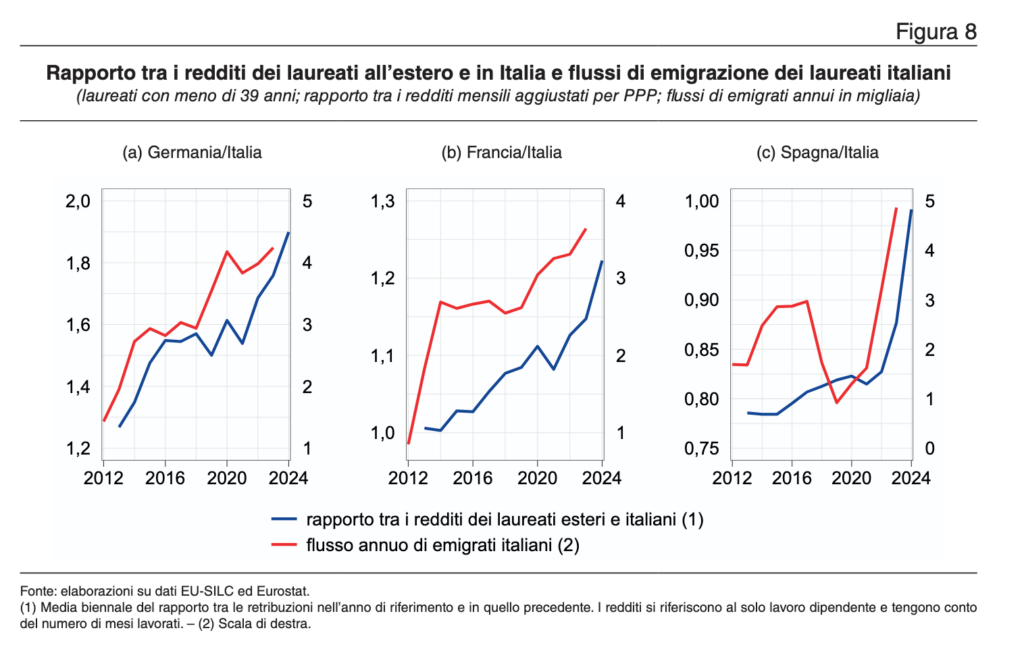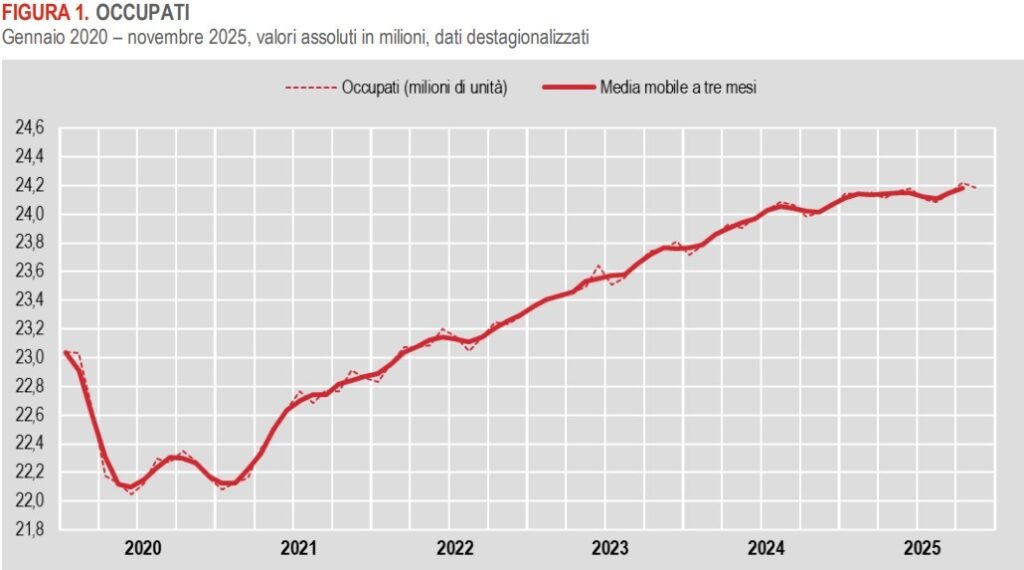Il curriculum ti apre la porta del lavoro, ma è il colloquio che decide se puoi metterci dentro il piede. Federica Romagna, coach che da anni affianca imprese e candidati, Top voice di LinkedIn che collabora con l’Osservatorio Delta Index, parte da qui per smontare alcune illusioni diffuse tra le aziende: «Il colloquio resta fondamentale, ma può diventare un boomerang se gestito male, se condizionato dai pregiudizi o ridotto a un esame tecnico». Il rischio? Perdere talenti preziosi, allungare i tempi di ricerca, alimentare turnover e frustrazione. Un tema cruciale che il Rapporto Delta Index ha messo sotto la lente: solo il 9% delle imprese considera oggi la selezione una priorità, eppure dal modo in cui viene gestita dipende gran parte della competitività futura.
I bias che invecchiano l’azienda
I primi nemici sono i pregiudizi inconsci – i bias – e quello dell’affinità è uno tra i più comuni: «Scelgo chi mi assomiglia, chi ha studiato dove ho studiato io, chi tifa la mia squadra. Così costruisco team omogenei che non innovano, che non portano pensiero divergente». Gli effetti non sono solo individuali: «Quando si sbaglia a selezionare figure chiave – un direttore vendite, un responsabile marketing – l’errore si ripercuote a cascata su tutto l’organigramma». L’Osservatorio Delta Index lo conferma: il 40% delle aziende si limita a colloqui standard, senza strumenti per valutare soft skill, creatività, capacità di adattamento. Una prassi che «invecchia» l’impresa, rendendola meno attrattiva proprio agli occhi dei giovani.
Il silenzio del ghosting
L’altra grande ferita nei processi di selezione è il silenzio. Quell’atteggiamento chiamato «ghosting»: dopo un colloquio, anche dopo più di uno, l’azienda sparisce senza spiegazioni. «Su questo fenomeno ci sono almeno due spiegazioni: una organizzativa e una culturale. La prima è che spesso i recruiter hanno poco tempo per gestire anche le risposte – spiega Romagna –, la seconda invece è un problema di cultura aziendale che non considera il feedback parte integrante del processo». Per le imprese l’effetto reputazionale può essere devastante: «I ragazzi parlano tra loro, e oggi i social amplificano ogni esperienza negativa. Basta un post su TikTok perché l’immagine aziendale crolli».
Feedback: nutrire il futuro
Romagna insiste su un concetto spesso trascurato: «Feedback, composto da “to feed” e “back”, vuol dire letteralmente “restituire nutrimento”. L’etimologia ci aiuta: non è solo dire no, non è un consiglio, ma è una restituzione che possa essere utile al miglioramento». Una risposta costruttiva, anche se breve, aumenta la fiducia e il rispetto verso l’azienda, trasformandosi in un vantaggio competitivo. Eppure, secondo il Delta Index, solo un quarto delle imprese utilizza strumenti per valutare e comunicare soft skill e potenziale. Il resto si limita a risposte standard o al silenzio. Così si perdono occasioni di relazione che potrebbero consolidare il legame con le nuove generazioni.
Dal difetto al potenziale
Le tre regole d’oro
Quali sono allora le caratteristiche minime di un buon processo di selezione? Romagna le sintetizza in tre parole: chiarezza, trasparenza, restituzione.
Chiarezza: avere da subito un elenco di competenze da ricercare e domande mirate sugli indicatori comportamentali.
Trasparenza: dire esattamente quale ruolo si propone e quali saranno mansioni e condizioni, senza promesse generiche.
Restituzione: dare sempre un feedback, positivo o negativo, personalizzato. «Troppi giovani – racconta Romagna – si ritrovano a svolgere un lavoro molto diverso da quello descritto al colloquio. Questo mina la fiducia e aumenta il rischio di abbandono precoce».
La tecnologia non basta, ma serve
Un altro fronte da non sottovalutare è quello dei software di recruiting e dell’intelligenza artificiale. Sempre più aziende li adottano per accelerare la fase di screening dei curriculum o per gestire grandi volumi di candidature. «Sono strumenti utili – spiega Romagna – perché riducono i tempi e aiutano a standardizzare i processi, ma non possono sostituire la sensibilità del selezionatore». La tecnologia, infatti, è efficace nel misurare dati, cronologie o parole chiave, ma rischia di fermarsi in superficie. «Un algoritmo non è in grado di cogliere l’aspetto umano, la motivazione, la storia che c’è dietro – osserva Romagna –. Per questo l’IA deve essere un supporto, non un sostituto. È la capacità di relazione del recruiter a fare la differenza». C’è infine un nodo spesso ignorato: chi forma chi seleziona? «Il recruiting non è un’attività che si improvvisa. Servono competenze, conoscenza dei bias, capacità di osservare e di restituire feedback. Troppi recruiter sono senza preparazione adeguata».
Ripensare la selezione
Serve dunque un processo strutturato, inclusivo, capace di leggere il potenziale oltre i titoli. Un passaggio che non è solo tecnico, ma culturale. Perché, come conclude Romagna, «alla fine non scegliamo curriculum: scegliamo persone. Ed è dall’aspetto umano che dipende la vera differenza».